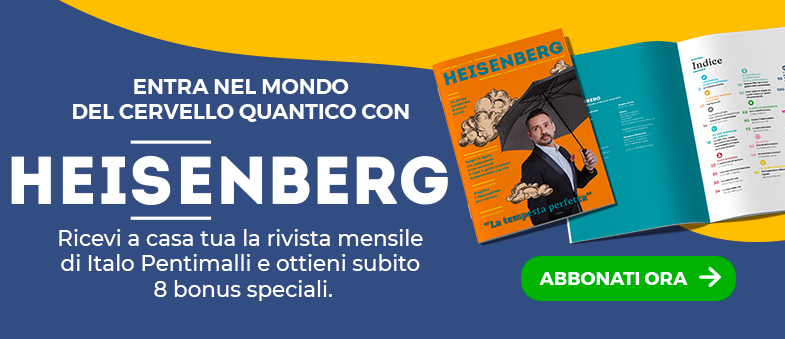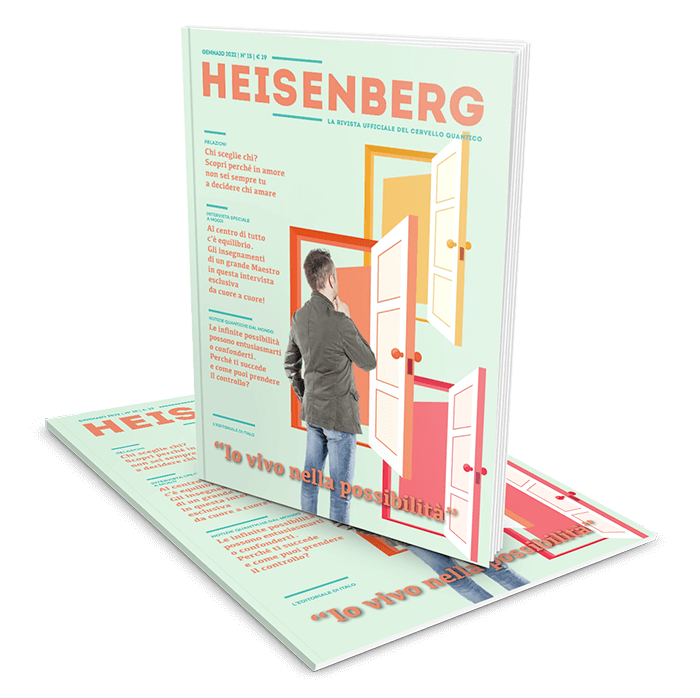È vero che le parole possono cambiare la realtà ed è anche vero che la parola può far il mondo in modo diverso.
Se la mente è lo strumento più potente con cui l’uomo affronta la realtà, una mente che non sa esprimere quello che ha dentro è impotente.
Anzi, di più, riusciamo a comprendere i confini della nostra mente, a capire davvero noi stessi, a cercare di farci capire dagli altri o viceversa a sforzarci di comprendere gli altri, tutto grazie alle parole.
L’invenzione più potente della mente.
Ecco perché sono andato a intervistare una delle persone più famose in Italia che si occupa di parole, la sociolinguista Vera Gheno, ricercatrice all’Università di Firenze, autrice e traduttrice di molti libri dall’ungherese e conduttrice di un podcast prodotto da “Il Post”.
Con lei cercheremo di capire quanto è stretto il rapporto fra le parole e la nostra percezione del mondo; quando le parole possono migliorarci ma anche umiliare, e come fare a difendersi in questi casi; se noi siamo le nostre parole o siamo molto di più.
E in che misura e in che senso le parole possono cambiare la realtà.
Un’intervista intensa ma ricchissima di spunti su cui riflettere per arricchire la vostra mente.

Le parole sono il ponte tra mente e realtà
Dunque, presentare Vera Gheno non è così semplice.
Tu sei un personaggio pubblico, una nota studiosa, una divulgatrice che ha scritto molti libri. Tecnicamente sei una sociolinguista. Ma, al di fuori di certi ambiti specialistici, la maggior parte delle persone non sa bene di cosa si occupi una sociolinguista.
Ce lo spieghi tu?
Innanzitutto diciamo che questa della “sociolinguista” è un’etichetta che ho adottato per spiegare facilmente alle persone cosa faccio.
Giacché ho sempre avuto una vita lavorativa ricca di attività, occupandomi di social media, insegnando in università da contrattista, facendo divulgazione e spettacoli, era sempre difficile far capire alle persone di cosa mi occupassi.
Ecco perché l’etichetta generalista di sociolinguista.
Detto ciò, la sociolinguistica è la materia in cui mi sono laureata.
Che cos’è? È una disciplina al confine fra tante altre materie come la linguistica, la sociologia, la filosofia del linguaggio e l’etnografia.
E cosa fa? Usa il pretesto della lingua per studiare le persone nella loro individualità ma anche come membri della società o nicchie della società.
Studia come la lingua cambia nel tempo, nei gruppi sociali e anche nei diversi mezzi di comunicazione.
Nel mio approccio specifico, la sociolinguistica è un modo per valutare come vivono le persone, quanto stanno bene e cosa provoca loro malessere, cioè quand’è che le parole diventano motivo di fastidio anziché motivo di felicità, mettiamola così.
E questo è perfetto per la nostra rivista e anche per il tema del mese che è dedicato alla mente. Dico perfetto perché le parole sono il ponte fra la mente e la realtà.
A una prima analisi le parole sono una sorta di codice con cui identifichiamo le cose. Ci capiamo con le persone del nostro gruppo perché condividono lo stesso codice con noi, ad esempio per noi italiani la dimora dove viviamo è “casa”, per gli inglesi è “home”, per i francesi “maison”, ecc.
Ma quando abbiamo a che fare con cose più immateriali – l’amore, la politica, la fede – diciamo che la traduzione fra mente e realtà è molto meno efficace. Perché?
Noi esseri umani non viviamo solo nominando cose pratiche, la finestra, il computer, il telefono con cui sto parlando.
Ma dato che siamo esseri infinitamente complessi abbiamo molte possibilità cognitive e quindi ci interroghiamo su come definire cose intangibili come sentimenti, paure, pulsioni, tutte “cose” mentali.
Tirare fuori cose dal cervello e dare loro un nome è qualcosa di molto potente che ha conseguenze varie e assortite.
Mi viene in mente la psicoanalisi: riuscire a dare forma verbale a ciò che ti fa star male ti aiuta a stare meglio.
Oppure, pensiamo all’amore, che non è fatto solo di gesti pratici e sesso, ma da sempre ci spinge a tradurre in parole tutte quelle sue sfumature che ci fanno star bene e che sono importanti per noi esseri umani.
Quindi tornando a quello che dicevi prima tu riguardo il rapporto fra lingua e mente, senza le parole quello che la mente produce rimarrebbe chiuso dentro.
Fra tante discipline la linguistica ha moltissimo a che fare con quello che succede all’interno del nostro cervello. Con un piccolo paradosso, cioè che è ancora abbastanza misterioso come funziona la nostra mente in relazione alla lingua.
Le parole creano la realtà?
C’è un altro aspetto in cui le parole fanno da ponte fra mente e realtà: quando abbiamo a che fare con l’identità di ognuno di noi.
Perché più io sono in grado di chiarire bene con le parole quello che penso e sento, e più chiara è a me stesso la mia identità. Ce lo spieghi tu questa specie di rispecchiamento fra ognuno di noi e le sue parole? Noi siamo le nostre parole?
Questa è una versione un po’ estrema della realtà, però serve a sottolineare un aspetto del rapporto con le parole che spesso sottovalutiamo.
Il linguista Giorgio Cardona diceva che tramite le parole noi spieghiamo agli altri chi siamo, chi vorremmo essere e chi pensiamo di essere.
Quindi dire “noi siamo le parole che usiamo” è una semplificazione, ad esempio spesso attraverso le parole noi cerchiamo di migliorarci.
Tu però hai parlato di rapporto fra identità e parole, ed è un rapporto strettissimo.
Pensa semplicemente al fatto che quando nasciamo ci viene assegnato un nome, e poi per buona parte della vita raccogliamo etichette per rispondere alla domanda “chi sono?”, cioè usiamo le parole per definire i confini di ciò che siamo.
Questa costruzione dell’identità individuale, man mano che entriamo in relazione con gli altri diventa collettiva, cioè scopriamo che facciamo parte di una comunità di parlanti la stessa lingua, al cui interno vi sono sottogruppi che si distinguono anche per il loro posizionamento culturale e quindi come vedono il mondo.
Per dirla semplicemente, noi siamo animali sociali, e senza la comunicazione con gli altri non esprimiamo al meglio la nostra umanità.

Hai detto che le parole ci aiutano a migliorarci. O ci identificano, come singolo e gruppo.
Ma dietro quelle parole ci sono delle programmazioni emotive con cui siamo cresciuti, e che formano la nostra visione del mondo.
Se vogliamo usare una metafora informatica, le programmazioni sono le istruzioni per capire la realtà, e le parole sono i codici con cui queste istruzioni si fanno capire all’esterno.
Quindi, quando abbiamo problemi con la realtà, problemi di relazione, problemi di identità, non basta cambiare le parole ma anche le programmazioni, la carica emotiva delle parole. Tu che ne pensi?
Prima di toccare il tema delle programmazioni emotive devo sfatare un luogo comune che è implicito nel tuo ragionamento, e cioè che ad ogni parola corrisponde un significato.
La lingua è bastarda, frutto di incroci, i concetti possono essere espressi con tante sfumature, oppure una stessa parola può avere a seconda dei contesti significati diversi.
Pensa alla parola carta, può essere intesa come carta d’imbarco, carta da gioco, carta di credito…
Il fatto che le cose non sono nominate in un modo solo, comporta che la comunicazione è faticosa, non bastano le parole che abbiamo acquisito crescendo. Se tutto cambia e nuove cose si affacciano alla nostra cognizione, anche le parole devono cambiare, mentre altre vengono usate meno.
Il terzo aspetto da sottolineare è che le parole sono ganci verso mondi di significati e quindi verso modi diversi di pensare.
Se io uso la parola “pro-life”, o l’espressione “gestazione per altre persone” oppure “utero in affitto”, non sto semplicemente usando una definizione al posto di un’altra ma sto facendo capire agli altri come la penso su quell’argomento.
Quindi, se le parole sono ganci verso mondi di significati e di emozioni diversi è facile non intendersi e quindi bisogna negoziare. Solo che negoziare costa fatica: entrare nello stato d’animo dell’altro comporta l’adozione di meccanismi mentali diversi che non sempre siamo disposti a seguire.
Un bel concetto che può aiutarci è quello della “carità interpretativa”: cioè partire dal presupposto che l’altra persona sta facendo del suo meglio per spiegarsi e più di così non sa fare.
Vuol dire mettersi nello stato d’animo di accettare l’imprecisione e chiedere all’altro di trovare assieme i significati condivisi alle parole.
Il potere della parola
Ti faccio una domanda apparentemente semplice. Le parole possono cambiare la realtà? Trasformarla?
Dico che è semplice solo in apparenza perché da un lato c’è chi crede che la parola giusta può fare miracoli. Dall’altro discipline come la psicologia e la psichiatrica, che si basano essenzialmente sullo scavo interiore attraverso la parola, non sempre ottengono risultati.
Tu, dal tuo punto di vista, che idea hai del potere delle parole sulla realtà?
Il potere della parola è antico come l’uomo.
Dai miracoli della Bibbia alle formule sciamaniche si è sempre creduto che le parole possono cambiare la realtà.
E in un senso molto pragmatico è vero, le parole possono cambiare la realtà, pensa al battesimo, all’arresto, l’assoluzione, la promozione a un esame, sono tutti atti linguistici che producono conseguenze nella realtà.
La mia non è una posizione di fede indiscussa nel potere della parola, né una posizione di menefreghismo verso la parola perché tanto contano solo i fatti.
Per me il linguaggio cambia la mia realtà individuale, porta felicità a noi stessi, nella misura in cui ho più parole o parole più chiare per nominare ciò che non conosco, quindi posso vivere più pienamente la vita, con meno paure.
Però è anche vero che la parola può far vedere alcuni aspetti del mondo in modo diverso.
Pensiamo ad esempio all’inclusività. C’è un passaggio del libro di Iacopo Melio che si intitola È facile parlare di disabilità (se sai davvero come farlo) che dice “Se cambiamo la definizione di quel qualcosa cambierà la percezione che le persone hanno di quel qualcosa, cambieranno anche gli atteggiamenti verso quel qualcosa e cambieranno anche i fatti che riguardano quel qualcosa.” Per me è un po’ questo il potere migliorativo della parola nei confronti della realtà che condividiamo.
Tu hai citato prima gli atti linguistici che possono cambiare la realtà. Ma queste sono azioni esteriori.
Le parole invece possono compiere trasformazioni interiori, in positivo o negativo.
Se io sono un genitore o un insegnante e dico a un ragazzo “questa strada non fa per te” compio un’azione mortificante per la sua autostima. Viceversa, a volte basta un incoraggiamento per convincere qualcuno a perseguire un suo talento.
Quindi la domanda è: se le parole hanno questo potere, chi ascolta come può trasformare la loro influenza se per lui è dannosa?
Ci sono parole che ci ghettizzano, che ci umiliano o ci precludono delle possibilità sociali, ed è difficile dare una risposta in questi casi.
Posso provare a fare degli esempi concreti di come neutralizzare le parole che fanno male. Uno è il cosiddetto “reclaiming”, cioè il prendere le parole offensive e renderle inoffensive usandole.
Pensiamo alla parola “queer” che in origine voleva dire “strano” e veniva usata in modo offensivo, e la comunità queer l’ha usata per definirsi.
Così come l’insulto nigger per la comunità afroamericana. Un altro modo è di far notare che una parola o un giudizio risultano offensivi o discriminanti.
Quanto meno serve a costringere chi ti manca di rispetto a prendere coscienza che il gioco è scoperto.
C’è poi una riflessione sul valore che diamo all’umiliazione.
Etty Hillesum, la scrittrice ebrea morta ad Auschwitz, diceva che per l’umiliazione ci vogliono due persone, una che umilia e l’altra che sta a farsi umiliare. E quindi il modo per neutralizzarla è ignorarla, non darle alcuna considerazione, perché l’umiliazione è tale se uno la sente.
Quindi bisogna lavorare su come io, persona umiliata, percepisco l’umiliazione, per poi rifiutarla.

Portiamo un po’ a terra tutte queste discussioni.
Tu che ha dedicato tutta la tua vita professionale allo studio delle parole, puoi suggerire degli esercizi quotidiani che possono fare tutti per migliorare il loro rapporto con la realtà grazie alle parole?
Secondo me è una questione di atteggiamento su cui si può lavorare.
Noi abbiamo un istinto ancestrale di ostilità nei confronti dello sconosciuto, ma essendo un istinto possiamo controllarlo sforzandoci di passare dalla paura del nuovo alla curiosità del nuovo.
Il consiglio pratico che mi sento di dare è di accostarsi in maniera curiosa a ciò che non si conosce.
Ciò che non si conosce non è l’esotico ma quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, non so vai a lavoro in metro e chiediti: perché le fermate si chiamano in quel mondo?
Sono sempre stupefatta di quanto poco sappiamo del mondo in cui viviamo. Le domande a cui rispondere sono ovunque.
Perché quel negozio si chiama in quel modo? Chi ha inventato il nome della Rinascente?
Ci sono mille spunti dalla realtà di tutti i giorni che meritano approfondimento.
Dobbiamo demistificare la conoscenza, essere curiosi, e la curiosità passa attraverso le parole.
Pensiamo che la cultura sia una cosa fighetta che si trova dentro i libri, e non ci rendiamo conto che viviamo in mezzo alle parole come i pesci vivono in mezzo all’acqua. Questa non è mia ma di David Foster Wallace.