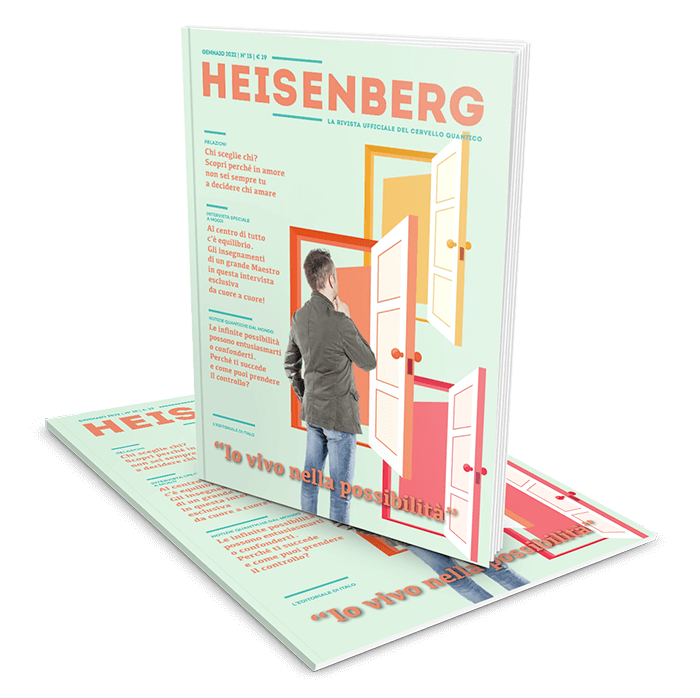Quali condizionamenti impediscono alla Scienza di andare oltre certe convinzioni sulla mente e la coscienza? Ma se oltre la consueta visione ci fosse molto altro?
Chi conosce il mio pensiero sa quanto le nostre inconsapevoli programmazioni condizionano le nostre vite. Questi schemi sono gli strumenti attraverso cui la nostra mente interpreta il mondo, e sono molto potenti.
Questo discorso vale anche per la comunità di scienziati e filosofi, ad esempio quando parliamo di materia e spirito, corpo e coscienza. Anche gli scienziati sono influenzati da vecchie idee radicate che hanno il potere di condizionarne la visione.
Ma se riuscissimo a superare questi limiti che scenario si aprirebbe?
L’ho chiesto al professor Enrico Facco, studioso senior di Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università di Padova, esperto di terapia del dolore, autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche e diversi libri, tra cui, i più recenti, L’enigma della coscienza (con Fabio Fracas) e Ritornare a Ippocrate. Riflessioni sulla medicina moderna (con Silvano Tagliagambe).
Quello che si apre è uno scenario senza limiti, in cui passato e futuro si uniscono in una visione straordinaria di ciò che siamo… e del nostro potere.
Faccio una premessa per i nostri lettori. Oggi scienziati e filosofi si dividono fra chi ritiene che la “coscienza” sia qualcosa di riducibile al funzionamento del cervello, e chi ritiene che sia un meccanismo molto più ampio e profondo che va al di là della materia del cervello. Professore, lei come si colloca in questo dibattito?
Decisamente sul secondo fronte. La coscienza è definita dalle neuroscienze come una proprietà emergente dalla complessità del cervello. Se è così, la nostra mente non è totalmente riducibile al cervello per coerenza con il concetto stesso di proprietà emergente. Per capire il dibattito attuale sulla coscienza bisogna risalire a Cartesio. È stato lui che ha creato questo “dualismo” fra mente e materia, una visione che continua a influenzare in maniera più o meno consapevole il pensiero occidentale.
La separazione radicale cartesiana tra mente e materia aveva lo scopo di evitare un conflitto insanabile con la Chiesa, che reclamava l’esclusiva competenza sull’anima; così da allora la scienza si è limitata allo studio del solo mondo fisico per circostanze politico-religiose e non per ben fondate ragioni di conoscenza scientifica e filosofica.
Quindi è un condizionamento culturale potentissimo, tanto che anche il senso comune separa materia e spirito. Ma oggi? Che evoluzione sta avendo in ambito scientifico questo tipo di visione?
Oggi, per quanto la situazione sia molto cambiata, il dualismo cartesiano influenza ancora fortemente molti studiosi. L’approccio scientifico classico ha separato l’osservatore dal mondo, come se l’osservatore fosse neutro e privo di ruolo nella definizione del fenomeno osservato, fatto clamorosamente smentito dalla fisica quantistica, che ci ha dimostrato come l’osservatore influenza la realtà. La stessa fisica quantistica ha superato il concetto classico di materia rendendo obsoleto il materialismo fondato su di esso e ha aperto nuove rivoluzionarie prospettive per una migliore comprensione della dimensione della coscienza.
Mi spiego meglio. Da un lato, nello studio della coscienza il “riduzionismo scientifico”, cioè il metodo che identifica i circuiti neurali alla base dei vari fenomeni mentali, è un metodo valido e potente e non è in discussione. Tuttavia quando il processo di riduzione fosse completato, nella visione materialista rimarrebbero solo i circuiti cerebrali e la coscienza sparirebbe; e con questo sparirebbero anche tutti i suoi contenuti e l’esperienza.
A proposito di “contenuti” della coscienza, lei studia da tempo le “Esperienze di pre-morte”, quei fenomeni di persone clinicamente morte che ritornano in vita raccontando di aver visto quello che succedeva intorno a loro. Non si tratta di parapsicologia ma appunto fatti clinici che vengono studiati in tutto il mondo dalla medicina. Perché sono importanti e perché rimettono in discussione la natura stessa della realtà fisica?
Le esperienze di pre-morte (in inglese NDE) e le esperienze di uscita dal corpo (OBE) hanno accompagnato la storia dell’umanità di tutti i tempi e di tutte le culture, dal mito di Er nella Repubblica di Platone, al Libro Tibetano dei Morti alla II Lettera di San Paolo ai Corinzi. A partire dagli anni ’70 del secolo scorso questi fenomeni apparentemente bizzarri e a priori considerati mera espressione di disordini cerebrali, hanno cominciato ad essere studiati scientificamente e oggi una considerevole mole di dati è disponibile nella letteratura internazionale.
Diverse ipotesi di matrice riduzionista sono state formulate nel tentativo di spiegare questi fenomeni, tuttavia nessuna di esse è stata dimostrata finora, mentre alcune sono facilmente smentibili sulla base di altri fatti noti incompatibili con le ipotesi formulate. Dunque le NDE costituiscono una forte sfida alle conoscenze attuali e al paradigma dominante in medicina. Come diceva lei, ci sono alcuni casi ben documentati nella letteratura scientifica di soggetti che riportano percezioni esatte di ciò che avveniva intorno a loro mentre erano in arresto cardiaco, fatto che appare incompatibile con le attuali conoscenze sulla coscienza.
In sintesi, le NDE non hanno nulla in comune con il sogno né con il delirium, e hanno un indubbio valore cognitivo, perché tutte le persone che le hanno provate vanno incontro ad un’evoluzione della visione personale e del mondo e perdono la paura della morte, il più angoscioso dilemma dell’umanità. Inoltre sono esperienze transculturali: gli elementi più importanti di queste esperienze − come il tunnel, la luce, l’incontro con le persone defunte, la straordinaria serenità − sono infatti comuni a tutte le culture e tutte le epoche storiche. Potremmo definirle quindi “archetipiche”, espressione di quel vasto e ancora sconosciuto inconscio collettivo.
Ecco, andiamo oltre la fisiologia del cervello. Lei usa una bella analogia: come nel mondo delle particelle quantistiche queste vivono in uno stato di perenne indeterminazione finché l’azione di un osservatore non le fa “collassare” in uno stato reale, concreto, così esiste un piano in cui convivono tutte le idee possibili, e l’artista, l’inventore, lo scienziato, grazie alla loro azione mentale ne rendono reale una singola fra tutte le altre. E questo vale per qualunque momento in cui passiamo dal nostro ragionare inconscio a una scelta precisa. Insomma, è giusto dire che viviamo immersi in un campo di infinite possibilità mentali di cui noi sfruttiamo solo una minima parte?
Sì! Si tratta di un’analogia, che non presuppone l’esistenza di processi fisici quantistici nel cervello, ma riguarda il nostro modo di conoscere la parte più profonda di noi. Dopo avere pensato per secoli che la coscienza e la razionalità fossero il fondamento dell’essere umano è oggi chiaro che la coscienza ordinaria è come una minuscola isoletta che galleggia in un mare di psiche inconscia con cui siamo in una continua comunicazione. Questa psiche è universale, come il concetto di inconscio collettivo suggerisce. Ma questo l’uomo lo sa da sempre.
Se guardiamo all’antico Oriente e la sua saggezza, già prima di Cristo nel testo buddista del Laṅkāvatārasūtra, troviamo il concetto di “coscienza fondamentale” o “coscienza deposito”, la base primordiale inconscia della coscienza nel continuum mentale che include l’Io. Nello Zen è descritta la Buddhadatu, la parte più profonda dell’inconscio, comune a tutti gli esseri senzienti. Quindi più di duemila anni fa il buddismo parlava già di un inconscio molto più profondo di quello psicanalitico e di un fondo comune a tutte le diverse forme di coscienza, comprendenti quelle degli animali. Il punto è come comunichiamo con questa parte profondissima di noi. Lei dice che ne sfruttiamo solo una minima parte. È vero. Infatti nell’antica Grecia, l’Arte era figlia della Memoria. Se ci pensiamo, il vero artista, ma anche il grande scienziato come Einstein, deve avere la rara capacità di attingere alle profondità dell’inconscio per portare alla luce i più profondi e universali significati a beneficio di tutta l’umanità. Questa è la ragione per cui Platone diceva che conoscere è in realtà ri-conoscere.
La fisica quantistica ha scoperto e dimostrato l’entanglement – cioè la connessione fra due particelle a distanza. Oggi alcuni studiosi ipotizzano l’entanglement fra persone, si parla anche di una forma non locale di coscienza, cioè non racchiusa nel cervello di ognuno.
Quindi questo vuol dire ipotizzare che la coscienza possa essere un campo di informazioni non locale?
Nella letteratura scientifica internazionale c’è una crescente mole di articoli, soprattutto di matrice quantistica, che ipotizzano una non-località della coscienza. È un’ipotesi apparentemente assurda per la visione classica ancorata al principio di causalità e località, ma non è per questo da considerare falsa a priori. Parallelamente stanno emergendo nuove dimostrazioni di meccanismi quantistici di diverse funzioni biologiche, impensabili fino agli anni recenti; le ipotesi quantistiche della coscienza, come la recente teoria di Penrose e Hameroff, pur non ancora dimostrate, stanno acquisendo nuove evidenze a loro favore.
Da millenni sappiamo che la coscienza emerge e dipende dal cervello: in termini molto semplici, se il cervello è sano l’individuo è cosciente, mentre una sua lesione può portare a perdita della coscienza, la quale poi riappare se le lesioni cerebrali guariscono. Questo non dimostra tuttavia che la coscienza sia residente nel cervello e sia un suo esclusivo prodotto. Infatti se, come esperimento mentale, si ammette una relazione mente-cervello analoga a quella tra Internet e il PC, il funzionamento è identico: se il PC funziona, ci si può collegare a Internet, mentre se si rompe questo non è più possibile finché non venga riaggiustato. Tuttavia Internet continua a esistere e a veicolare informazioni in modo non locale anche se il singolo PC è danneggiato. In conclusione, l’osservazione clinica della relazione mente-cervello non dimostra di per sé la residenza della coscienza nel cervello. Ovviamente è solo un’ipotesi senza pretesa di verità, ma finché non viene falsificata non può essere esclusa a priori su base assiomatica.
E quindi, per concludere, a cosa ci apre tutto ciò?
La scienza della coscienza è nata negli anni ’80 del secolo scorso, ossia oltre tre secoli dalla nascita della scienza moderna. La coscienza è un argomento che coinvolge molte discipline e ha profonde implicazioni epistemologiche e metafisiche, letteralmente che vanno oltre la realtà fisica. Ne è un segno il fatto che gli unici scienziati che se ne sono occupati seriamente nella prima metà del XX secolo sono stati i fisici quantistici e non i neurologi né gli psicologi.
Il paradigma dominante del materialismo, che abbiamo visto fin qui, non è costitutivamente idoneo né sufficiente a comprendere il mondo della coscienza e dei fenomeni soggettivi. Per farlo dobbiamo superare il dualismo mente-materia che risale a Cartesio e dobbiamo avere un approccio più ampio che consenta di reintrodurre la soggettività come parte ineludibile della realtà. Non è un caso che il pensiero antico − in particolare i filosofi presocratici, il taoismo e il buddismo − con il suo approccio non dualista sia molto più compatibile con il paradigma della fisica quantistica rispetto al pensiero occidentale post-aristotelico.
Nel taoismo, ma anche in Eraclito, era già perfettamente chiara la reciproca trasformazione e complementarietà di tutti gli opposti, compresa la relazione materia-energia e mente-corpo nel divenire del mondo. L’Occidente moderno ci è arrivato dopo 2500 anni con la fisica quantistica. L’energia si trasforma ma non si nullifica e la materia è costituita da energia concentrata e particelle virtuali in sé prive di massa, che emerge dal vuoto quantistico. Dunque tutto si trasforma ma nulla si crea e si distrugge.
La realtà non è costituita di enti separati e indipendenti dotati di esistenza intrinseca autonoma, ma è un sistema complesso inscindibile di eventi intercorrelati in eterna trasformazione, incessante scambio di informazioni e coevoluzione.
Condivido in pieno la sua visione. Sembrerebbe un ritorno all’antica saggezza delle religioni ma aggiornata dalla scienza.
Proprio così. È un’idea che ricorda il dio progenitore dei Veda, Prajāpati, che dà origine al mondo per poter essere riconosciuto e poi si ritira dietro le quinte come sfondo dell’apparire, depositario dell’ineffabile ignoto. L’idea del riconoscimento sembra una bella metafora per indicare la coscienza che rappresenta il mondo, senza la quale esso stesso non esisterebbe. Pensiamoci, l’esistenza infatti – dalle singole particelle, alle cellule e poi alle persone – richiede la trasmissione di informazioni che vengono recepite per poter apparire. Senza questo passaggio di informazioni, a qualsiasi livello, non c’è relazione. In conclusione, forse la coscienza, intesa nel suo senso più ampio ed elementare, ossia la capacità di recepire e trasmettere informazioni, potrebbe rivelarsi una dimensione costitutiva dell’universo esistente.